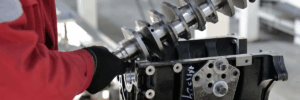Last Updated on December 27, 2019
Di: Avv. Wanda Falco
Secondo l’art. 2087 c.c., norma cardine del sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore è tenuto a garantire l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la salute fisica e psichica dei propri dipendenti. Tale obbligo impone all’impresa di evitare tutti quei comportamenti che possano creare un ambiente di lavoro ostile che rischia di incidere sulla integrità psico-fisica del dipendente
A tal riguardo, si è sempre parlato di mobbing inteso come condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, che si risolve in reiterati comportamenti ostili concretantisi in forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psichico-fisico e del complesso della sua personalità (Cass. 11777/2019).
In tempi recenti, tuttavia, è sempre più frequente il riconoscimento da parte delle Corti di una forma più attenuata di mobbing, detto straining, che presenta alcune tratti distintivi cui è bene fare attenzione.
La giurisprudenza, infatti, partendo dall’art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, ritiene che il datore sia tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente anche nella forma di condizioni lavorative stressogene idonee a causare un danno alla salute.
Vediamo nel dettaglio che differenza c’è tra il mobbing e lo straining e le più recenti pronunce in materia.
Mobbing vs straining: analogie e differenze
Tradizionalmente la giurisprudenza definisce il mobbing come quel complesso di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi (Cass. 12437/2018; Cass. 26684/2017).
Si tratta di un illecito che si configura, dunque, se ricorrono due elementi:
- l’elemento oggettivo, ovvero la ripetizione nel tempo di una pluralità di condotte vessatorie, l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente e il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
- l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio comune a tutti i comportamenti lesivi, non meramente colposi.
In sostanza, il mobbing ha una struttura riconducibile a quella del reato abituale, inteso come reato nel quale il comportamento criminoso viene prodotto dalla reiterazione nel tempo di più condotte omogenee (es. stalking).
Lo straining, invece, si differenzia dal mobbing per il modo in cui è perpetrata la condotta illecita: non è necessario il carattere della continuità delle azioni vessatorie.
Quindi, la differenza fondamentale tra lo straining e il mobbing risiede nel fatto che nel primo caso sono sufficienti anche poche azioni isolate, mentre nel secondo la continuità delle azioni vessatorie costituisce un elemento imprescindibile.
Lo straining è, dunque, una forma attenuata di mobbing, una condizione psicologica posta a metà strada tra il mobbing e il semplice stress occupazionale. Esso si configura quando vi siano comportamenti stressogeni che producono effetti dannosi permanenti nel tempo, scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero e distanziate nel tempo (Cass. 15159/2019; Cass. 18164/2018).
Esistono, tuttavia, alcune pronunce recenti che ritengono configurabile lo straining anche in assenza di prova dell’elemento soggettivo dell’intento persecutorio delle condotte vessatorie. In sostanza, il datore di lavoro è tenuto ad evitare “situazioni stressogene che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno più tenue anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio” (Cass. 3291/2016; Cass. 7844/2018; Cass. 18164/2018; Cass. 24883/2019).
Alcuni casi di riconoscimento dello straining
Essendo lo straining una forma attenuata di mobbing diventa più agevole il suo riconoscimento mancando la necessità di accertare la pluralità di condotte vessatorie e l’esistenza di un preciso intento persecutorio.
In sostanza, ai fini della configurazione dello straining anche un’unica azione ostile o più azioni prive di continuità sono sufficienti purché provochino delle conseguenze durature e costanti a livello lavorativo tali per cui la vittima abbia percepito di essere in una continua posizione di inferiorità rispetto ai suoi aggressori.
Si pensi al caso della dottoressa dell’Asl che aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da mobbing e demansionamento, oltre al risarcimento per le ingiurie subite dal suo superiore. I giudici di appello accoglievano solo la domanda per danni da ingiuria e nel merito del mobbing rilevavano che risultavano provati solo due episodi. In uno il primario aveva avuto nei suoi confronti un atteggiamento aggressivo culminato con il gesto di stracciare una sua relazione e in un’altra circostanza lo stesso primario non aveva volutamente consegnato la scheda di valutazione della donna.
Ad avviso della Corte i due episodi, per quanto gravi, non costituivano mobbing, ma dovevano essere qualificati come straining dal momento che la vittima aveva sì subito in conseguenza di essi disturbi di adattamento con ansia e umore depresso, ma le azioni ostili erano limitate nel numero e distanziate nel tempo (Cass. 3291/2016).
Un altro caso interessante è quello del dipendente di banca che era stato progressivamente allontanato dalla direzione generale e aveva ricevuto delle lettere di scherno diffuse sul luogo di lavoro. In tal caso gli episodi accertati, anche se distanziati nel tempo e, come tali, non rientranti nei parametri del mobbing, erano stati tali da provocare nel dipendente situazioni di stress fonte di grave frustrazione (Cass. 7844/2018).
Sono state, inoltre, qualificate come straining e non come mobbing le condotte tenute nei confronti di un’impiegata amministrativa di una scuola consistite nella immotivata privazione degli strumenti di lavoro, nell’assegnazione di mansioni incompatibili con lo stato di salute e nella riduzione in una condizione di umiliante inoperosità (Cass. 3977/2018).
Profili processuali: il giudice può qualificare la condotta datoriale come straining se il lavoratore chiede il danno da mobbing?
Un profilo interessante è sicuramente quello relativo alla possibilità che si verifichi una violazione dell’art. 112 c.p.c. in materia di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nel caso in cui il giudice qualifichi come straining la condotta vessatoria denunciata dal lavoratore come mobbing.
Diverse pronunzie hanno spiegato che non può ipotizzarsi alcuna violazione del principio della domanda per il fatto che, mentre il lavoratore nell’atto introduttivo del giudizio ha fatto riferimento al mobbing, il giudice ritenga di qualificare la fattispecie come straining: infatti, si tratta soltanto di adoperare differenti qualificazioni di tipo medico-legale per identificare comportamenti puntualmente allegati e provati nel giudizio. In sostanza, se è vero che non è consentito al giudice di pronunciarsi su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita diverso da quello domandato o fondato su fatti diversi da quelli rappresentati, è, tuttavia, in suo pieno potere-dovere qualificare giuridicamente la domanda in maniera diversa o porre a fondamento della decisione valutazioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalle parti (Cass. 3977/2018; Cass. 18164/2018; Cass. 3291/2016).
Pertanto, una volta accertato il compimento di una condotta contraria all’art. 2087 c.c., senza dare rilievo all’originaria prospettazione della domanda giudiziale in termini di danno da mobbing e non da straining, il giudice può giungere ad una diversa qualificazione senza mutare il petitum e la causa petendi e senza attribuire al lavoratore un bene diverso da quello domandato.
Ciò ha un impatto notevole in quanto il lavoratore, che sostiene di aver subito un danno da mobbing, non rischia di vedersi rigettare la domanda qualora non siano provati tutti i requisiti costitutivi della fattispecie, ma può ottenere in ogni caso un risarcimento del danno, seppur in forma attenuata.
Conclusioni
Negli ultimi anni si è assistito a un progressivo riconoscimento da parte dei giudici di questa nuova figura di danno alla salute del lavoratore che ha alleggerito gli oneri probatori a suo carico; si tratta, infatti, di una fattispecie di illecito che si configura anche in assenza della reiterazione costante nel tempo delle condotte vessatorie e di un intento persecutorio, tutti elementi che hanno sempre reso difficile la prova del mobbing. Indubbiamente in questo modo si amplia significativamente la tutela del lavoratore nei casi di condotte vessatorie ed ostili compiute dal datore di lavoro che, una volta accertate, garantiscono sempre un risarcimento in favore della vittima per violazione dell’art. 2087 c.c. anche a prescindere dall’originaria qualificazione della domanda giudiziale.
In ogni modo, che si tratti di mobbing o di straining, i giudici sono sempre chiamati ad accertare la sussistenza in capo al lavoratore di un danno alla sua integrità psico-fisica eziologicamente riconducibile al comportamento vessatorio del datore di lavoro.
“